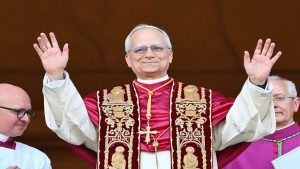una riflessione sulle crisi del lavoro e il potere umano che trasforma
Mentre il mondo si confronta con crisi lavorative sempre più frequenti, la notizia della chiusura delle attività di Chiquita Brands a Bocas del Toro, in Panama, risuona come un’eco amara. Oltre 6.500 persone hanno perso il lavoro nel giro di poche settimane, dopo mesi di tensioni e proteste legate a riforme contestate e a condizioni sociali precarie. Il danno economico stimato supera i 75 milioni di dollari, ma il costo umano è incalcolabile.
In questo scenario, parlare di gentilezza può sembrare fuori luogo. Forse addirittura ingenuo. Eppure, è proprio nei momenti di rottura e disillusione che la gentilezza dimostra la sua forza trasformativa.
Gentilezza non è semplicemente cortesia. È la capacità, profondamente umana, di ascoltare, di comprendere e di scegliere un’azione che tenga conto dell’altro. È un modo di costruire relazioni — nel lavoro come nella politica — basato sulla dignità e sul rispetto, anziché sulla reazione o sulla convenienza.
Immaginiamo cosa sarebbe potuto accadere se, sin dall’inizio, il dialogo tra lavoratori, azienda e governo fosse stato guidato da una reale volontà di ascolto e cooperazione. Se ci fosse stato spazio per la vulnerabilità condivisa, per l’empatia autentica. Se la gentilezza fosse stata intesa come competenza strategica, capace di prevenire conflitti, costruire fiducia e tenere insieme le comunità anche nei momenti più incerti.
La gentilezza non risolve tutto, ma può cambiare il modo in cui affrontiamo i problemi. Può essere il primo passo per costruire modelli di impresa, di lavoro e di governance più sostenibili e più umani.
In un’epoca in cui la disumanizzazione è spesso una scorciatoia per il profitto, riscoprire la gentilezza come scelta radicale non è un lusso: è una necessità.